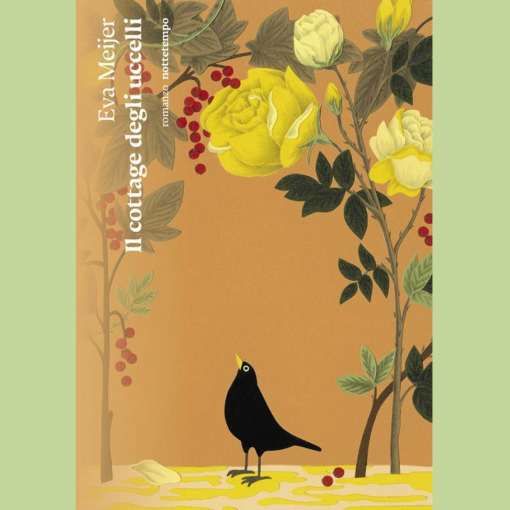Ovunque si passeggi, dal piano alla zona submontana, lungo i sentieri, ai margini dei coltivi, è facilissimo passare accanto ad una pianta che nell’aspetto ricorda la pianta del cetriolo, ma che, se urtata, spruzza qualcosa: è il Cocomero asinino, chiamato anche Momordica (Ecballium elaterium).

Il suo nome botanico, che deriva dal greco έκτο (ecto) = al di fuori e βάλλω (ballo) = lanciare, fa appunto riferimento ad una particolarità dei frutti: “sparare” i semi il più lontano possibile! All’interno dei frutti si sviluppa una pressione idraulica notevole che, quando il frutto è maturo, al minimo tocco lascia fuoriuscire liquido e semi. La pressione che si accumula in un frutto maturo è addirittura superiore a quella di uno pneumatico d’auto, tanto che quando il frutto si stacca dal peduncolo il liquido ed i semi vengono sparati fuori ad una velocità di circa 10 m/s e ad una distanza anche di oltre 12m! I semi sono contenuti in un liquido vischioso che permette loro di attaccarsi alle piume degli uccelli o al pelo dei mammiferi. Disperdere i suoi semi il più lontano possibile permette alla pianta di colonizzare luoghi anche molto lontani.
Il Cocomero asinino che, come suggerisce il nome volgare appartiene alla famiglia delle Cucurbitacee, ha fiori maschili e femminili; è una pianta velenosa anche se molto utilizzata nella farmacopea per le sue innumerevoli proprietà medicinali.
Continuando nella nostra passeggiata, possiamo notare le bacche ovoidali riunite in mazzetti, “nate” dalle fioriture autunnali dell’Edera (Hedera helix) che cominciano a scurire. L’Edera, che tutti conosciamo, è una pianta ubiquitaria, invasiva, che vegeta allo stato spontaneo abbarbicandosi ai muri, alle rocce, ai tronchi, oppure aderisce al suolo divenendo tappezzante. In ogni caso preferisce luoghi freschi, umidi ed ombrosi.

È una specie arbustiva, lianosa e sempreverde che può raggiungere i 20 m di lunghezza. I fusti volubili, riescono ad arrampicarsi e ad aderire a qualsiasi substrato grazie alle radici avventizie, emesse in corrispondenza dei nodi delle ramificazioni. La capacità dell’Edera di emettere radici dal fusto e di di aderire con grande tenacia al substrato, fa sì che sia ampiamente coltivata e diffusa a scopo ornamentale per ricoprire muri e pergole in mezz’ombra.
Considerata erroneamente pianta parassita, l’Edera non usa le radici avventizie per succhiare la linfa delle piante, ma per “agganciarsi” ai diversi sostegni per raggiungere la luce. Essa contribuisce alla selezione naturale del bosco: quando “abbraccia” i tronchi li appesantisce e fa cadere gli alberi meno resistenti e già malati, accelerando così il rinnovo del bosco e il completamento del suo ciclo biologico.
Altra caratteristica interessante da osservare è la spiccata eterofillia che caratterizza questa specie: le foglie dei rami giovani che strisciano sul terreno o si arrampicano sulla parte bassa dei tronchi, hanno forma palmato-lobata, mentre sui rami che producono fiori e poi frutti più alti, in pieno sole, le foglie sono ovato-romboidali.
Tutte le parti della pianta, in particolare le foglie giovani e le bacche, sono tossiche per l’uomo.
Ma le sue bacche ovoidali, prima verdi, poi rossastre, infine nero-bluastre a maturazione, che contengono 2 o 3 semi oblunghi, rugosi e rossicci nutrono un gran numero di specie di uccelli: Colombacci, Pettirossi, Codirossi spazzacamino, Merli, Capinere, Tordi (sassello e bottaccio), Cinciarelle, Rigogoli, Ghiandaie, Gazze, Cornacchie (grigia e nera), Storni, Crocieri, Frosoni, Strillozzi!
Le pigne di Pino domestico (Pinus pinea) invece, contengono semi molto gustosi per gli esseri umani di ogni età: i pinoli.
Gli strobili, nome scientifico di quelle che chiamiamo pigne, sono sessili, cioè sono attaccati direttamente al ramo, o muniti di un brevissimo peduncolo; li troviamo solitari o abbinati e molto pesanti e resinosi. Le squame spesse, bruno-rossicce e lucide, terminano in un largo scudo piramidale. Ogni squama porta 2 pinoli protetti da un guscio legnoso, ornato da un’ala rudimentale e ricoperti da una polverina nero-purpurea. Per gustare questi semi tanto prelibati, però, bisogna aspettare che maturino per ben tre anni!

L’habitat di questo bellissimo albero sempreverde è rappresentato dai litorali marittimi. Il Pino prospera in terreni sciolti e sabbiosi sino a 500÷600 m s.l.m. e nelle aree più calde fino a 800÷1000 m. Ricopre estesamente le dune sia con pinete pure, sia associato a Pinus pinaster, Quercus ilex, Quercus frainetto, Quercus robur e ad altre latifoglie sclerofille mediterranee.
È una specie monoica ha, cioè fiori maschili e femminili sulla stessa pianta e, come tutte le conifere, utilizza l’impollinazione anemofila, la forma più antica di trasporto del polline: i fiori femminili vengono impollinati dal vento.
I pinoli non piacciono solo a noi, fanno gola a molte specie di uccelli e di piccoli roditori. Lo Scoiattolo (Sciurus vulgaris), ad esempio, è un grande consumatore di questi semi. Si alimenta soprattutto stando sugli alberi. Per terra, in corrispondenza dei rami su cui si alimenta troviamo decine e decine di pigne desquamate. Le pigne desquamate dagli scoiattoli nell’intento di raggiungere i pinoli hanno un aspetto “sfrangiato”, con la base sfilacciata, e in cima un ciuffetto di squame. Topi ed Arvicole, invece, preferiscono rosicchiare le pigne sul terreno e lasciano meno squame in cima alle pigne.
Il Picchio rosso maggiore (Picoides major) solitamente mangia le pigne sopra un tronco d’albero o incastrandole in una cavità della corteccia. Se non ne trova una adatta, la crea con poderosi colpi di becco. Dopo aver staccato le squame, con la lingua estrae i semi. Per estrarre il pinolo dal seme procede in modo originale: fa un buco nella corteccia dell’albero, vi incastra il seme e con un colpo netto del becco lo rompe per estrarne il pinolo. Terminata la prima metà della pigna, il picchio la rigira e ricomincia con l’altra parte.

Il Crociere (Loxia curvirostra) invece, mangia direttamente dalle pigne attaccate sull’albero senza staccarle, utilizzando il suo robusto becco ricurvo, caratterizzato dagli apici superiore ed inferiore uncinati ed incrociati, per divaricare e sgusciare con facilità le pigne, usando in seguito la lingua per nutrirsi dei semi in esse contenuti.
Nel Pino cembro (Pinus cembra) le pigne, che maturano dopo due anni, anche se cadute dall’albero restano chiuse. Contengono semi molto saporosi che vengono mangiati dagli scoiattoli e dagli altri roditori ma soprattutto dalla Ghiandaia (Garrulus glandarius) e dalla Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes), corvidi che, secondo alcuni Autori, aiuterebbero notevolmente la diffusione del Pino cembro. Il cembro è molto amato anche dai Cervidi alpini che ne fanno spesso, quando la stagione è propizia, la base del loro nutrimento.

La specie vegeta ottimamente in climi a spiccata continentalità, venendo condizionata marcatamente nella sua diffusione proprio da tale carattere tipico di ambienti subalpini ed alpini. In Europa ha la sua maggior diffusione nelle Alpi austriache, da cui si irradia sia verso ovest che verso est.

Secondo gli studiosi, il centro d’origine di questo pino, che vegeta dai 1100 ai 2500 m e fa parte di un aggregato di specie, sarebbe l’Asia settentrionale, da cui nell’era terziaria e quaternaria è pervenuto in Europa; durante le glaciazioni ha trovato rifugio in Austria, Svizzera ed Italia settentrionale, per diffondersi poi notevolmente, nel periodo post-glaciale, nelle aree elevate delle Alpi centrali. In seguito l’areale è risultato in forte contrazione, sia per fattori climatici, sia antropici (disboscamento, pascolo, incendi) e sia, infine, per concorrenza di altre conifere; attualmente, per la riduzione o l’abbandono dell’attività alpicolturale, si assiste ad una moderata espansione del pino negli ex pascoli.
Crediti
Autore: Anna Lacci è divulgatrice scientifica ed esperta di educazione all’ambiente e alla sostenibilità e di didattica del territorio. E’ autrice di documentari e volumi naturalistici, di quaderni e sussidi di didattica interdisciplinare, di materiali divulgativi multimediali.