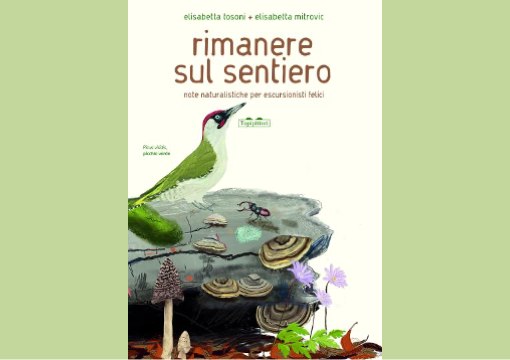Il settore leader dell’industria dell’abbigliamento da 15-20 anni è in costante mutamento; una vera e propria rivoluzione ha indirizzato molti brand verso la produzione di collezioni ispirate all’alta moda, ma messe in vendita a prezzi molto contenuti e rinnovate in tempi brevissimi, per soddisfare il bisogno di essere sempre al passo con le ultime tendenze ispirate da influencers e testimonials famosi.
È la fast fashion, una moda svelta, pratica, creativa, economica e soprattutto alla portata di tutti.
La troviamo pubblicizzata sulle riviste, sui social, nei grandi manifesti; la troviamo in vendita nelle vie dello shopping delle città.
È un modello di produzione che porta gli stilisti a creare continuamente nuove collezioni basandosi sulle richieste del mercato, andando oltre le tradizionali collezioni primavera/estate e autunno/inverno su cui si basavano le collezioni del prêt-à-porter e dell’haute couture. È molto economica e con poche decine di euro si può tranquillamente rinnovare il guardaroba e gettare via senza rimpianti i capi fuori moda e/o usati pochissimo. Spesso è venduta su piattaforme digitali, che permettono di restituire senza costi di reso ciò che non soddisfa le aspettative.
Ognuno può così, con pochi soldi, creare facilmente il proprio stile, la propria immagine

Per questi motivi soprattutto in tempi di crisi economica come gli attuali, viene considerata dalla massa una grande risorsa e questo fa sì che all’interno del fast fashion si movimentino grandi capitali.
Il valore del fast fashion nel mercato globale raggiunge cifre da capogiro. Era di 91,3 miliardi di dollari nel 2021, nel 2022 ha raggiunto i 99,23 miliardi; il trend, in costante crescita vertiginosa, potrebbe arrivare nel 2026 a 133,43 miliardi di dollari. (Report Statista 2022). Oltre 50 milioni di lavoratori sono impiegati nei laboratori di produzione.
I prezzi bassi dei singoli capi producono l’effetto illusorio di avere un risparmio, così ogni anno nel mondo acquistiamo circa 80 miliardi di nuovi capi d’abbigliamento, il triplo dei capi che si acquistavano 30 anni fa, tanto che dal 2000 al 2020 l’acquisto dei capi d’abbigliamento è aumentato del 400% . Si comprano troppi indumenti a basso costo, si produce troppo.

Dal 1975 al 2018, la produzione è passata da 6 a 13 kg di vestiti a persona, ma il 10% di ciò che si produce viene gettato nelle discariche prima ancora di entrare nei negozi,
I capi acquistati vengono conservati per periodi brevissimi, anche meno di una stagione e ogni volta che riordiniamo i nostri armadi gettiamo via indumenti indossati pochissime volte.
Di pari passo è diminuita la qualità, sia dei materiali che della confezione.

Questa moda a poco prezzo ha purtroppo un costo importante che è pagato da altre persone e dall’ambiente, perché nel mercato globale nessuno regala niente; se si paga un prezzo stracciato per un prodotto, qualcun altro sta pagando la differenza in termini di danni all’ambiente, alla salute umana, ai diritti umani
Quanto costa al sistema Terra?
Studi recenti collocano l’industria dell’abbigliamento al secondo posto dopo il petrolio come inquinante mondiale
Una ricerca pubblicata su Nature Reviews Earth & Environment e riportato da Focus, conferma la tendenza già rilevata in uno studio del 2018:
• l’industria della moda (tessile, abbigliamento, accessori, calzature,…) con 4.000-5.000 milioni di tonnellate di CO2 rilascia annualmente nell’atmosfera, circa l’8-10% delle emissioni globali, più del totale di tutti i voli internazionali e del trasporto marittimo messi insieme. Basti pensare che la produzione di un paio di jeans coinvolge ditte di 4 continenti: le varie componenti con cui viene realizzato un paio di jeans possono viaggiare fino a 65.000 km.
• con 190.000 tonnellate, è colpevole dell’accumulo negli oceani di oltre un terzo delle microplastiche. La fast fashion ha introdotto l’uso di tessuti più economici, ma altamente nocivi, fibre come poliestere, nylon e acrilico sono plastiche che contribuiscono all’inquinamento generato dalla plastica: con un bucato di poliestere vengono sprigionate nell’ambiente 700000 fibre di microplastica.
• contribuisce per il 20% alla contaminazione industriale dell’acqua in tutto il mondo. Sono 2.700 i litri d’acqua necessari a produrre una sola maglietta, l’equivalente del fabbisogno d’acqua di una persona per due anni e mezzo
• produce più di 92.000 tonnellate annue di rifiuti tessili (tra cui rientrano anche i capi di abbigliamento invenduti o scartati, avanzi di soluzioni coloranti e tessuti rovinati a causa di trattamenti impropri) oltre. 300.000 tonnellate di vestiti dismessi, destinati alla discarica o all’incenerimento.
Una parte dei capi che buttiamo via viene spedito in Africa in balle chiamate Mitumba, parola che in lingua swahili significa di “seconda mano”, destinate ai mercati locali. Essendo materiale di scarsa qualità finisce presto in discariche sempre più grandi, tanto che a Nairobi, in Kenia, ogni anno circa 20 milioni di kg di rifiuti tessili devono essere smaltiti dalla città.
Nel deserto di Atacama il più arido della Terra, sulla costa occidentale del Cile, si stima che ogni anno vengano scaricate illegalmente circa 39.000 tonnellate di vestiti usati di vario tipo e materiale, provenienti dall’Europa, dall’Asia e dagli Stati Uniti, compromettendo un territorio unico al mondo.

Fortunatamente in Italia il Distretto Tessile di Prato porta avanti una tradizione secolare di riciclo, riuscendo a lavorare 34.00 tonnellate di rifiuti tessili all’anno destinati a importanti progetti di up-cycling.
I costi umani
Come può una t-shirt costare così poco, anche 3 euro? Sicuramente nel processo produttivo oltre al mancato rispetto delle più elementari norme sul rispetto dell’ambiente, il costo della manodopera è un fattore importante. Se i lavoratori europei o americani costano troppo, basta spostare la produzione in paesi terzi dove non esistono tutele per i lavoratori, dove il concetto di diritto dei lavoratori è sconosciuto; paesi come l’India, la Cina, la Cambogia o il Bangladesh dove il costo della manodopera è molto basso e una giornata di lavoro di 12/16 ore viene pagata 1,90 – 2,40 dollari (dati presi dalla Rosita Factory in Bangladesh riportati nel documentario “Fashion victims” di Sarah Ferguson).
Spesso i lavoratori (anche bambini) sono costretti a lavorare in condizioni di mancata sicurezza, a contatto con sostanze tossiche, talvolta incatenati alle macchine da cucire, in pessime condizioni igienico-sanitarie, in fabbriche con strutture fatiscenti. Si può parlare di sfruttamento umano se non di vera e propria schiavitù.
Allora, noi donne che celebriamo l’8 Marzo in ricordo di123 operaie e 23 operai che morirono nel rogo della fabbrica di abbigliamento Triangle Shirtwaist (NY) nel 1911, dobbiamo anche ricordare il 24 aprile 2013 quando a Savar, un sub-distretto nella Grande Area di Dacca, capitale del Bangladesh, a causa di un cedimento strutturale, crollò il Rana Plaza, un edificio commerciale di otto piani causando 1.129 vittime, quasi tutte donne. L’edificio ospitava diversi negozi e una banca, ma soprattutto numerose fabbriche di abbigliamento low cost per conto di noti marchi di abbigliamento europei che davano impiego a circa 5.000 persone.
Ecco il prezzo reale della t-shirt!

È vero che lo shopping è un’attività gratificante, anche consolatoria, però, prima di acquistare chiediamoci: Mi serve davvero quello che sto acquistando? Chi è che lo decide?
Crediti
Autore: Maria Beatrice Lupi. Naturalista, esperta in formazione, progettazione per lo sviluppo sostenibile, metodologie partecipative e progettazione europea. Attualmente si occupa di divulgazione e di educazione alla sostenibilità.